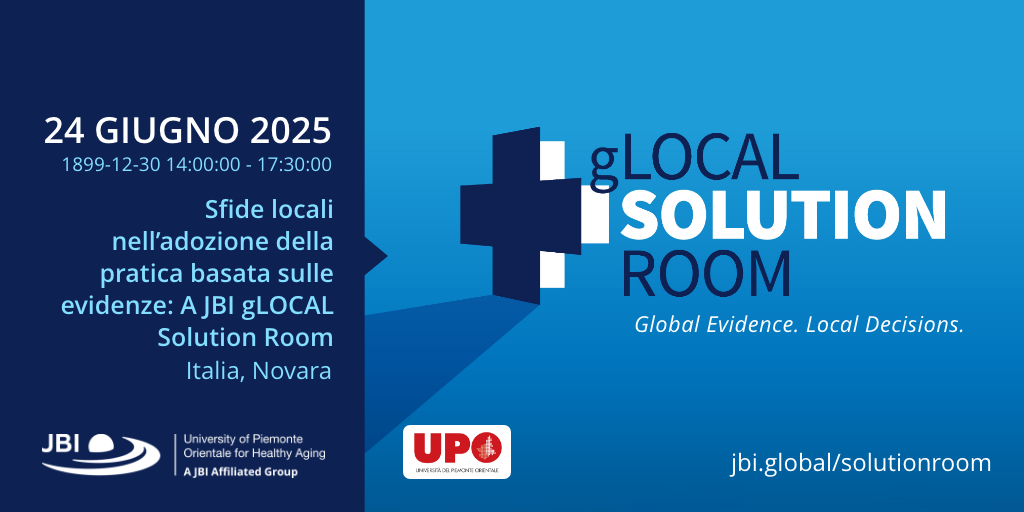Riferimento bibliografico
Joel Salinas et al. Association of Social Support With Brain Volume and Cognition. JAMA Netw Open, 2021 DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.21122
In sintesi
Qual è l’associazione tra diverse forme di supporto sociale e la resilienza cognitiva?
La resilienza cognitiva è la capacità di essere meno suscettibili alle modificazioni nella struttura del cervello dovute all’età e alla malattia e mantenere prestazioni cognitive migliori di quelle attese.
Per esempio, volumi cerebrali ridotti sono generalmente associati a funzioni cognitive ridotte: in questo studio trasversale, i ricercatori hanno esaminato l’effetto modificante delle forme di supporto sociale sul rapporto tra volume cerebrale, misurato con risonanza magnetica, e prestazioni cognitive, misurate con test neuropsicologici. Ne è risultato che un’alta disponibilità di ascolto attivo è associata a una funzione cognitiva globale migliore rispetto a quella che ci si aspetta per un diminuito volume cerebrale.
Per altre forme di supporto sociale questa associazione è risultata assente: pertanto potrebbe essere giustificato promuovere specifiche forme di supporto sociale, come l’ascolto attivo, negli interventi psicosociali e nelle strategie di salute pubblica per favorire la salute neuro-cognitiva.
Il contesto e il punto di partenza
La resilienza cognitiva è la differenza tra le prestazioni cognitive attese e quelle effettive di un individuo, data la sua struttura cerebrale e il livello di vulnerabilità ai cambiamenti neuropatologici. I potenziali fattori di miglioramento della resilienza cognitiva includono il livello di istruzione, l’attività fisica e mentale e le relazioni sociali.
Gli studi suggeriscono che disporre di reti sociali di supporto riduce il rischio di malattia di Alzheimer e disturbi correlati (ADRD, Alzheimer Disease and Related Disorder), migliorando la resilienza cognitiva. Sono scarsi, però, i dati sugli specifici meccanismi messi in gioco dal supporto sociale. Da qui la necessità di esaminare la correlazione tra singole forme di supporto sociale, la funzionalità cognitiva e un marcatore neuroanatomico globale e precoce della vulnerabilità all’ADRD.
Le caratteristiche dello studio
Con un’analisi retrospettiva trasversale, i ricercatori hanno utilizzato i dati prospettici raccolti dallo studio Framingham, una grande coorte longitudinale basata sulla popolazione, che ha coinvolto 3 generazioni. Questo studio utilizza i dati della coorte originale, delle persone arruolate nel 1948 e quelli della generazione seguente, arruolate nel 1971, includendo solo partecipanti maggiori di 45 anni, non affetti da demenza, ictus o altre condizioni neurologiche, che sono stati sottoposti a risonanza magnetica cerebrale, test di valutazione del supporto sociale e test neuropsicologici.
In particolare, sono stati utilizzati i dati relativi al volume cerebrale totale e alla disponibilità, auto-valutata, di cinque diversi tipi di supporto sociale misurati con il Berkman-Syme Social Network Index. La raccolta dei dati è stata effettuata dal 6 giugno 1997 al 13 dicembre 1999 (coorte originale) e dall’11 settembre 1998 al 26 ottobre 2001 (coorte dei figli). L’analisi dei dati ha avuto luogo dal 22 maggio 2017 al 1° giugno 2021. Lo studio ha incluso 2171 adulti (164 nella coorte originale e 2007 nella coorte dei figli; età media, 63 anni; 54% donne).
I risultati ottenuti
L’esito primario è stata una stima globale della funzione cognitiva. La resilienza cognitiva (β) è stata definita come la variazione nell’associazione tra il volume cerebrale totale e la funzione cognitiva, in modo tale che stime più piccole del valore β indicano una maggiore resilienza cognitiva (cioè, migliori prestazioni cognitive rispetto a quelle stimate per un volume cerebrale totale diminuito).
Un’elevata disponibilità dell’ascoltatore è risultata associata a una maggiore resilienza cognitiva (β = 0,08, P < .001) rispetto alla bassa disponibilità dell’ascoltatore (β = 0,20, P = .002). I risultati complessivi persistevano dopo l’aggiustamento per i potenziali effetti confondenti. Altre forme di supporto sociale non sono risultate significativamente associate (consigli: β = -0,04; P = .40 per interazione; amore-affetto: β = -0,07, P = .28 per interazione; supporto emotivo: β = -0,02, P = .73 per interazione; contatto sufficiente: β = -0,08; P = .11 per interazione).
Limiti dello studio
Un possibile limite di questo studio è che i partecipanti erano prevalentemente adulti bianchi; tuttavia, l’associazione complessiva del supporto sociale con la salute neurocognitiva è generalmente simile in coorti diverse da un punto di vista etnico. I risultati si basano, inoltre, su una valutazione auto-riferita della disponibilità di supporto sociale scelto tra 5 alternative piuttosto che su di una valutazione oggettiva di tutte le interazioni di supporto sociale. Nello studio si è tenuto conto di molti potenziali confondenti rilevanti ma non è esclusa la possibilità che non siano stati considerati altri confondenti capaci di influenzare i risultati complessivi.
Quali le novità
I risultati di questo studio suggeriscono che una specifica modalità di supporto sociale, l’ascolto attivo, è associata a una maggiore resilienza cognitiva, modificando in modo indipendente l’associazione tra i valori minimi di volume cerebrale totale e di funzione cognitiva.
Le prospettive future
I meccanismi neurobiologici sottesi richiedono ulteriori approfondimenti, utili per prevenire l’invecchiamento cognitivo: la disponibilità di un buon ascoltatore, ad esempio, potrebbe contribuire alla resilienza cognitiva attraverso meccanismi neurobiologici che promuovono diffusamente la plasticità sinaptica e la neurogenesi indotta dall’esperienza.
Una comprensione più raffinata dei meccanismi di supporto sociale ha il potenziale per informare le strategie di riduzione del rischio di ADRD e di miglioramento della resilienza cognitiva, giustificando la scelta di alcune specifiche forme di supporto sociale, come l’ascolto attivo, sulle altre nell’ambito di interventi psicosociali e di strategie di salute pubblica che promuovono la salute neuro-cognitiva.